Oggi si riapre, dopo tre anni, lo
splendido scenario della Scala di Milano.
Il Martirologio celebra
Sant’Ambrogio Vescovo di Milano. Per noi
milanesi è una festa particolare, cui fa eco -oltre alla celebrazione
dell’Arcivescovo nella Chiesa costruita dal Padre del Culto
Ambrosiano- la serata mondana scaligera. La riapertura, preceduta
quest’anno dalla visita del Capo di Stato, è attesa anche per gli
imponenti lavori di ripristino ed ampliamento con un nuovo edificio,
molto visibile e di forte “impatto/stacco” rispetto il disegno
originario della facciata voluto dal Piermarini.
Grande attesa anche per la presentazione delle musiche scelte dal
Maestro d’Orchestra, quest’anno molto “patriottiche”. Infine
trepidante attesa anche dei flash dei fotografi per gli scatti di
routine ai politici locali: il Sindaco di Milano, il Presidente della
Provincia di Milano e della Regione Lombardia.
L’architetto dell’edificio atteso e
criticato, discusso ma sempre impiegato per grandiosi progetti (si
pensi alla poliedricità dell’artista che
passa dalla progettazione del Casinò di Campione d’Italia, alla
ideazione di una cattedrale, alla Scala), è Mario Botta: nato a
Lugano, in Svizzera nel Canton Ticino,
elvetico di nascita, cosmopolita per vocazione.
Le sue scelte estetiche –discutibili o
ammirabili- hanno creato enormi “mode”, che svelano –se mal
riprodotte- l’artificiosità artigiana di coloro che tentano di emulare
lo “stile bottiano”.
E così il trionfo del mattone a vista
–quale elemento testurizzante delle sue
inconfondibili facciate- supera il mero rivestimento parietale esterno
e rivisita la storia dell’arte lombarda, memore del romanico, del
gotico internazionale si addensano nei suoi progetti.
Botta si apre mediante la razionalità ad
evocazioni evocative del patrimonio storico dell’architettura che ha
contraddistinto la preziosità degli artigiani del cotto -e del
“mattone”- per l’edilizia sacra , riproduce quello stile
architettonico di molte abbazie dell’Italia Settentrionale, divenuto
negli anni un carattere “distintivo”, re-inventando l’inimitabile
typos lombardo, creandone uno nuovo, tutto
suo da applicare ad edifici quale palazzi moderni, chiese, templi del
gioco d’azzardo…
La diocesi ambrosiana, la più grande del
mondo, ha una bella chicca “bottiana”. Si
trova in Brianza, poco fuori la periferia milanese, verso Lecco,
esattamente a Merate, un Comune prossimo
alle collina morenica di Montevecchia,
poco distante dal Fiume Adda e dai luoghi manzoniani.

La costruzione in questione è la chiesa di
San Pietro Apostolo, in Sartirana
Briantea, opera dell’architetto Mario
Botta, risalente all’anno 1992. La direzione dei lavori fu affidata
all’Arch. Fabiano Redaelli, che la curò
con passione nei minimi particolari, eseguendo quanto voluto dal
progettista. L’edificio sacro ha una superficie coperta di oltre
seicento metri quadrati, l’altezza complessiva è di quasi sedici
metri e un volume fuori terra di quasi diecimila metri quadrati.
Così descriveva l’architetto Mario Botta
la sua creazione: «Ho disegnato la “Casa di Dio” pensando alla “casa
dell’uomo”: la Casa di Dio non può che essere una parte di paesaggio,
di contesto, della città dove vive e opera l’uomo».
Tipologicamente,
la chiesa meratese, si pone visivamente
come un grande cubo in mattoni a vista all’interno del quale è
inserito un cilindro. A livello del piano terreno troviamo un
auditorium che misura quasi cinquecento metri quadrati, di cui oltre
cento sono di porticati, al primo piano l’aula per le celebrazioni per
una superficie complessiva di 485 metri quadrati.
Il volume cilindrico della chiesa è
modellato da due matronei: il primo per una superficie di quasi
trecento metri quadri, mentre il secondo, superiore, di mq. 300 da cui
si può vedere il rivestimento del cubo, il soffitto della Chiesa,
rivestito da pannelli termoacustici studiati appositamente.
La copertura, ritorna l’elemento quadrato,
è inserito una sorta di lanterna “a quadrotto”,
centrale, ribassata in modo da permettere l’accesso della luce
naturale. In realtà è la vera generatrice dello spazio interno, che
come dice Mons. Ravasi, Prefetto
Ambrosiana, nella sua presentazione: «l’architetto Mario Botta ha
saputo evocare un’epifania del divino e dell’invisibile attraverso il
fluire della luce che bagna e avvolge gli oggetti liturgici e l’intero
orizzonte della chiesa, i fedeli e la purezza cristallina delle
forme».
La struttura dell’edificio, per le cui
fondazioni si è resa necessaria la palificazione, è in calcestruzzo
armato completamente gettato in opera.
Il materiale dominante è il mattone rosso
fatto a mano, che riveste quasi completamente, esternamente ed
internamente, la struttura, con una tessitura disegnata per creare una
vibrazione continua della luce e del colore nelle mutevoli condizioni
del giorno e delle stagioni.
E ci associamo a quanto descrive Mons.
Gianfranco Ravasi: «un grande pittore,
Paul Klee, ha
scritto che "l’arte non deve rappresentare ciò che si vede ma nel
visibile deve svelare l’invisibile". È questa un po’ la sigla
spirituale della chiesa di S. Pietro a Sartirana.
Da un lato, infatti, essa è la presenza “calda” della realtà terrena
col sapore quotidiano del legno e del mattone, con l’assemblea degli
uomini e delle donne riuniti come in un grembo sereno dalla
circolarità della pianta centrale».
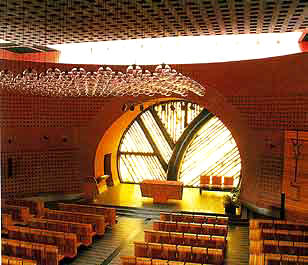
L’elemento decorativo incombe
sull’osservatore e lo stesso mattone, nel cilindro interiore dello
spazio della chiesa, è posto a diamante con funzioni fonoassorbenti;
le parti non rivestite dai mattoni sono trattate con stucco veneziano
a freddo in maggioranza di colore rosso (nero all’interno del primo
matroneo e giallo nell’auditorium).
I pavimenti sono in lastre di pietra (lavagrigia)
intercalate da listelli di marmo nero solo per il pavimento della
chiesa. La stessa lavagrigia è stata usata
per le scale di accesso alla chiesa. Per il sagrato si è impiegato
porfido a cubetti.
I serramenti sono in ferro ed alluminio
verniciati colore nero: quello absidale accoppia al vetro un
rivestimento in lastre di onice del Pakistan, di grande impatto visivo
sia entrando che dall’esterno, troneggiante e di grande resa che ben
celebra il ciclo dell’albero della
Vita
Il Prefetto della Biblioteca Ambrosiana
così lo descrive, recuperando quei valori simbolici che attingono alle
Scritture, in particolare al valore soterologico
che rimanda alle vicende della “Rivelazione di Gesù Cristo”
(l’Apocalisse giovannea): «l’albero della vita non domina solo la
vetrata centrale ma diventa anche l’asse che unisce finito e infinito,
tempo ed eterno, quotidianità e trascendenza. È in questa luce che la
struttura quadrata esterna diventa un simbolo della Gerusalemme
celeste del libro dell’Apocalisse, eretta «a forma di quadrato»
(21,16), segno di perfezione suprema e bellezza, e illuminata non più
dalla luce del sole e della luna ma dalla «gloria di Dio» e dalla
«lampada dell’Agnello» (21,23)». La zona absidale è animata dalla luce
che illumina l’abside in onice translucido, è realmente il simbolo
della grazia divina che illumina l’uomo che ricerca Dio. L’albero in
metallo ricorda la storia della redenzione (albero della vita nel
paradiso terrestre - albero della croce, altissimo il contenuto
teologico).
L’altare è interamente realizzato in legno
di rovere, come tutto l’arredamento. Segno per eccellenza
dell’Alleanza tra Dio e gli uomini, suggellata nella morte e
risurrezione di Gesù e resa attuale nell’Eucaristia qui celebrata.
Interessante l’utilizzo texturizzante del
lamellare e di ardite soluzioni geometriche essenziali che disegnano
forme purissime riprese anche nell’ambone. Quest’ultimo luogo dove la
Parola di Dio è proclamata durante la celebrazione, affinché ciascuno
possa accoglierla e meditarla per meglio vivere ogni giorno.
Vicino all’altare troviamo il tabernacolo
segno della presenza di Dio tra
gli uomini; è qui posto sotto il Crocifisso,
ci ricorda che l’Eucaristia, Pane vivo, è il Memoriale della Pasqua
del Signore.
Piccolo gioiello è il Fonte Battesimale,
ripete lo schema architettonico della chiesa (quadrato - cerchio). Qui
l’uomo viene purificato e inizia il suo cammino di fede e di salvezza,
entrando a far parte della Chiesa.
Le porte di accesso dall’esterno sono in
acciaio inossidabile. L’arredo sacro è realizzato in legno di rovere.
Di forte impatto nel contesto rurale della
campagna meratese, il nuovo edificio della
chiesa dialoga con la vecchia chiesina, prospiciente, a cui si è
aggiunta per esigenze di spazi. Discreto il rapporto con il centro
storico di Sartirana, modestissimo fatto
di piccole corti e villette random,
attraverso il sagrato che realizza la nuova vera piazza, luogo di
incontro e di vita della comunità.
Una Chiesa complessa che va “ascoltata”
cogli occhi e vissuta coi sensi. A tratti inquietanti per l’atmosfera,
quasi artificiale, ovattata, tipica di luoghi preziosi quali un
teatro, un auditorium ed anche una sala d’incisione.
Fotografie
delle opere bottiane